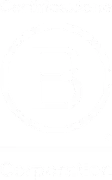“Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile": è l'Obiettivo 2 dell'Agenda 2030 dell'Onu.
Tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 dell'Onu, il secondo, così come il primo, sembrano, a prima vista, lontanissimi dalla nostra quotidianità e perseguibili solo, in minimissima parte, attraverso donazioni alle ONG che se occupano nel mondo. Anche questa volta il nostro tentativo è di riportare l'obiettivo vicino, illuminare i modi del nostro vivere quotidiano che aiutano a raggiungere l'obiettivo e quelli che, inconsapevolmente, contribuiscono ad allontanarlo.
Si legge sul sito dell’ASVIS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile: “Attualmente, a livello globale, soffrono la fame 821 milioni di persone. In Italia diminuisce la percentuale della popolazione in sovrappeso, aumenta la produttività del lavoro delle aziende agricole e si espande la superficie delle coltivazioni biologiche, ma occorre accrescere il contrasto alla povertà alimentare”.
Povertà alimentare che si definisce come l'incapacità degli individui di accedere ad alimenti sicuri, nutrienti e in quantità sufficiente per garantire una vita sana e attiva rispetto al proprio contesto sociale. Un fenomeno che riguarda ca. quattro milioni di persone nel nostro Paese.
E sebbene gli italiani in sovrappeso siano in riduzione, rappresentano ancora il 60% della popolazione.
Quindi non pochi stanno mangiando poco e male e in molti stiamo consumando troppo.
Anche a prescindere da cosa stiamo consumando, l’impatto negativo non è solo per la nostra salute o il nostro portafoglio, ma anche per la sostenibilità complessiva del sistema sia a livello locale che globale.
Di questo non sembra esserci grande consapevolezza né tra gli adulti, né tra i giovani, che pure mostrano una maggiore sensibilità ambientale.
Una ricerca Ipsos condotta lo scorso anno per conto della Fondazione Barilla sul rapporto tra giovani e SDGs e il ruolo del cibo nel loro raggiungimento, infatti, ha messo in evidenza che, anche tra chi conosce la sostenibilità (solo il 40% degli intervistati), soltanto un ragazzo su tre pensa che il benessere del Pianeta dipenda anche dall’alimentazione. Inoltre, sebbene sconfiggere la povertà e la fame sia considerato prioritario, sono obiettivi percepiti al di fuori dalla capacità d’intervento personale.
Questa una sommaria fotografia della situazione di contesto.
Andando sul piano delle percezioni e dei comportamenti individuali, gli Italiani che si dichiarano attenti alla relazione tra sostenibilità e alimentazione sentendo di essere coinvolti in prima persona, ritengono che il comportamento più impattante sia lo spreco alimentare, quindi ridurlo è la prima azione virtuosa da compiere. Vanno poi privilegiati i cibi a km 0, prodotti localmente e quelli con confezioni/imballaggi ridotti al minimo. Mangiare cibo di stagione e mangiare bene seguendo un regime alimentare sano è considerato importante da un numero ridotto di persone.
Tornando sullo spreco alimentare (che non è solo il cibo che buttiamo ma anche quello che rimane sui campi o invenduto), a guardarlo bene, questo vale quindici miliardi di euro, un punto percentuale del nostro prodotto interno lordo. Inoltre, a monte del prodotto acquistato che finisce nella spazzatura, c'è un capitale rappresentato da ettari di superficie agricola ed ettolitri di acqua oltre all'energia e al lavoro necessari per produrre quei beni che poi finiscono nella spazzatura. E non finisce qui, perché quanto buttato ha anche un costo per essere smaltito, quindi un costo ambientale ma anche economico e sociale visto che, come cittadini, paghiamo delle tasse per smaltire questi rifiuti.
Ma perché è così difficile oggi evitare gli sprechi alimentari? Buona parte di noi (almeno dai 50 anni in su) si ricorda di un tempo in cui c'era, in tutti gli ambienti sociali - anche nel più benestante – una attenzione molto maggiore a non sprecare il cibo così come anche altre risorse.
Da un certo momento in poi, complici la tecnologia e la globalizzazione, abbiamo avuto la disponibilità di tanto cibo, forse troppo. Troppo cibo fa sì che questo costi troppo poco e quindi gettarlo via sembra meno grave. In realtà, invece, costa veramente tanto. E’ stato calcolato che si tratta di poco meno di quattrocento euro all'anno di cibo buttato via pro-capite. Sembrano abbastanza ma forse non è una cifra così elevata da farci sentire ed essere sufficientemente sensibili e attivi nei confronti della lotta allo spreco.
Negli ultimi dieci anni,fortunatamente, da quando sono attive costanti campagne contro lo spreco alimentare, qualche cosa lentamente sta cambiando. Come sta cambiando l’attenzione di produttori e distributori all’incremento della sostenibilità in agricoltura e alla riduzione dell’impatto di tutto ciò che, diciamo, avvolge i nostri alimenti.
Ma la nostra economia fondata, fino al dopoguerra, sull’agricoltura dei contadini e dei territori si è trasformata, negli ultimi 50/60 anni, in una economia completamente industriale anche quando parliamo di agroalimentare. Questo ha allargato significativamente la distanza tra produttori e consumatori e tra gli uni e gli altri si sono frapposti così tanti altri interlocutori, che al consumatore arrivano sempre meno informazioni sul prodotto che si porta a casa e che poi mangia.
La nostra personale lotta alla povertà alimentare, quindi, non può che passare dal riappropriarci, in maniera diffusa e non elitaria, di un po' di competenza e di conoscenza su quello che mangiamo, dal riacquisire quella cultura ‘popolare’ del cibo che passava attraverso le famiglie e i territori, di generazione in generazione, e che dava valore e sacralità a un atto fondamentale per la nostra sopravvivenza come il mangiare.
Si tratta, quindi, di dedicare un po’ del nostro tempo e della nostra attenzione al cibo e alla sua produzione, al suo cammino dalla terra alla tavola, tornando a dare valore a quel cibo che mangiamo, a considerarlo un dono, il dono più grande della Natura a tutti gli esseri viventi. Tornando a sentire di essere noi stessi Natura attraverso quel cibo che dalla Natura viene e ci nutre.
Se diamo, in tal modo, autentico valore al cibo, certamente riduciamo gli sprechi e siamo anche più attenti e sensibili all’alterazione dei cicli naturali e al suo impatto sull’ambiente e sulla qualità dei nutrienti (pensiamo ad esempio agli effetti della coltivazione in serra e della conservazione in sofisticate celle frigorifere).
Ritrovare quindi l’abitudine a una alimentazione semplice (quella dieta mediterranea di tradizione antichissima che dal 2010 è stata anche riconosciuta “Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità” dall’UNESCO) fondata sul consumo di prodotti locali.
Consumare prodotti locali significa proteggere la biodiversità favorendo modelli di coltivazione in cui coesistono diverse specie animali e vegetali. Utilizzare prodotti freschi e locali consente di mantenere il più possibile inalterate le proprietà nutrizionali di molti prodotti con grandi benefici per la salute (“siamo ciò che mangiamo”).
Ma utilizzare prodotti freschi e locali contribuisce in maniera molto significativa anche alla sostenibilità sociale e alla sostenibilità economica dei territori perché consumare locale significa riuscire a mantenere l'identità, la consapevolezza alimentare delle persone che vivono sul territorio, il legame culturale con il territorio stesso e, inoltre, creare lavoro, creare reddito e mantenerlo, investendo sulla ricerca e sull’introduzione di tecnologie in grado di aumentare la qualità del prodotto in maniera rispettosa della sostenibilità ambientale e sociale.
Sconfiggere la fame, quindi, significa anche acquistare, mantenere, preparare e consumare meglio il nostro cibo quotidiano.
Ad aiutarci a farlo, da qualche mese abbiamo una preziosa guida a disposizione di tutti i cittadini per un’alimentazione più consapevole, sana e sostenibile. Sono le “Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana” (ed. 2018), realizzate dal CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, con il suo Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione, con l’intento di raccogliere e rielaborare le migliori evidenze scientifiche, coniugandole con le nostre tradizioni alimentari. Di questa riportiamo la tabella del cap. 13 come sintesi preziosa di indicazioni di buon comportamento alimentare consapevole e antispreco.