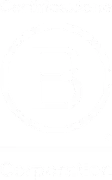«Il dottorino giovane del Fatebenefratelli, l’otorino, è proprio un amore, ancora non s’è guastato e speriamo che non si guasterà... Si vede che la mamma l’ha educato bene, è gentile con tutti, ti viene a prendere nella sala d’aspetto, e ti fa entrare prima di lui nello studio, proprio come si fa tra persone educate.
«Il dottorino giovane del Fatebenefratelli, l’otorino, è proprio un amore, ancora non s’è guastato e speriamo che non si guasterà... Si vede che la mamma l’ha educato bene, è gentile con tutti, ti viene a prendere nella sala d’aspetto, e ti fa entrare prima di lui nello studio, proprio come si fa tra persone educate. Anche se so’ vecchia e sorda… so’ sempre ‘na signora…, una donna insomma!
Con me poi è quasi affettuoso, mi mette sempre una mano sulla spalla quando mi saluta, e sorride come se fosse contento de vedemme. Ho parlato di lui anche con altri pazienti: è proprio il meglio… Lui ti fa sentire che conti qualcosa e che farà volentieri quello che può per te. E poi non se la tira, pare che si sente proprio uno come noi. Non come quelli scostumati, che se credono padreterni e te fanno sentì un poveraccio tutto sbaiato, uno scarto dell’umanità.
Io sono sempre contenta de vedello. Quando aspetto il turno, lo penso e sento gratitudine e perfino un po’ de tenerezza. Così l’apparato otoralango…etc. è quello che sta meglio, perché ci vado spesso da lui e so’ sempre pronta a fa’ tutte le cure che mi ordina. E poi mi piace parlarci anche quando me dice che so’ sempre più dura d’orecchi. Ma questo lo so già da me, però non glielo dico e faccio finta de preoccupamme. Così dopo un paio di mesi ce torno…».
Una questione di famiglia
Accade spesso di pensare che la gentilezza sia diventata fuoriluogo nelle relazioni sociali. La si incontra sempre più raramente nella quotidianità, quasi fosse un inutile orpello, una perdita di tempo, un eccesso di formalismo nella comunicazione – che si tende a ridurre drasticamente al necessario, a forme scheletriche di conversazione, all’osso. Il garbo, la finezza nell’avvicinarsi all’altro, la sensibilità che propizia l’incontro intimo e spirituale tra le persone sembrano banditi dalla socialità, talora anche da quella più personale e privata, perfino da quella familiare.
Le forme della conversazione tendono a diventare scarne, povere di aperture all’ascolto, foriere di isolamento e solitudine. Peccato, perché conversare è una virtù sociale di eccellente valore, ha a che fare con il reciproco convergere, con l’avvicinarsi gli uni agli altri, con il farsi compagnia, con l’uscire dunque dalla solitudine e dall’isolamento. In epoche trascorse si è promossa una autentica cultura della conversazione, nella quale le buone maniere erano viste come fulcro della socialità e rappresentavano la forma esteriore della gentilezza d’animo, della nobiltà dello spirito, della comprensione reciproca, della solidarietà.
Nei contesti sanitari, con l’affermazione del paradigma scientifico in medicina, si è andato progressivamente perdendo il valore dell’incontro personale tra curanti e pazienti e per conseguenza anche l’importanza della conversazione e della gentilezza come elementi qualitativi cruciali del prendersi cura. La formazione degli operatori sanitari privilegia gli aspetti quantitativi nell’indagine sulla malattia, lo studio della malattia attraverso gli strumenti che il progresso della scienza e della tecnologia forniscono ampiamente e in modo sempre più preciso. Per indagare la malattia, scontornandola dagli elementi soggettivi e psicologici legati alla persona che la incarna, i giovani operatori vengono formati a esercitare uno sguardo oggettivo e distaccato nei confronti del paziente, a erigere mura difensive che li mettano al riparo dalle emozioni dei pazienti e dalle loro stesse emozioni.
Peccato, perché in questo modo si realizza una duplice perdita: una mutilazione di se stessi, nella negazione della proprie emozioni al cospetto della sofferenza altrui e lo smarrimento di una chiave d’accesso cruciale per comprendere lo star male di un paziente, vale a dire di una persona che non può essere esaminata indipendentemente dal proprio vissuto di malattia e dalla propria biografia. La relazione risulta per conseguenza segnata da una duplice illusione cognitiva: la presunzione dell’operatore di potersi tirare fuori dal campo in cui agisce – fatto di forze molteplici di cui lui stesso è invece parte e che lui stesso con il suo sguardo e il suo agire influenza – e la conseguente messa in scena, per convincere se stesso soprattutto, della propria immunità rispetto al male che indaga – come se non fosse mai destinato a uscire dal proprio ruolo, per impersonare alle volte anche quello di malato.
A questo inganno cognitivo e formativo corrisponde una perversione nell’organizzazione dei luoghi deputati alla cura, che sembrano perdere progressivamente il loro intento etico e sociale di cura della fragilità e il loro carattere fondamentale di contesti nei quali si condivide il destino di precarietà e vulnerabilità comune a tutti gli esseri umani.
Per creare organizzazioni etiche e formare operatori consapevoli della loro comunione con il destino umano dei loro pazienti occorre la gentilezza…
Già perché la gentilezza ha a che fare con la parentela, con l’appartenenza a una stessa famiglia. L’etimo è illuminante. Il termine latino gens, da cui gentilis, allude proprio all’appartenenza a una medesima stirpe. Con il termine gentili si indicano originariamente gli appartenenti alla stessa stirpe, alla stessa famiglia.
La gentilezza dunque implica il riconoscimento di essere tutti membri di una stessa famiglia, riconosce un vincolo di parentela tra gli umani, un’affinità che ha ricadute etiche, politiche, di riduzione delle diseguaglianze, e non da ultimo pone in luce degli importantissimi effetti clinici. La gentilezza crea infatti intimità nelle relazioni, fiducia, soddisfazione anzitutto nei pazienti, che diventano parte attiva nell’alleanza con i curanti e manifestano una disposizione più fiduciosa a comprendere e aderire ai percorsi terapeutici.
Ma la gentilezza ha effetti virtuosi anche sui curanti: riduce i livelli di frustrazione connessi con l’inadeguatezza dei tempi e delle strutture organizzative, ed è un elemento cruciale nella formazione e nel consolidamento delle relazioni all’interno dei team terapeutici – relazioni che hanno la loro base, oltre che nella professionalità tecnica, che si dà per necessaria e presupposta, nella valorizzazione degli aspetti emozionali, intuitivi, etici.
La gentilezza è insomma una forma di intelligenza virtuosa che fornisce impulsi fruttuosi a tutti i livelli di una organizzazione, perfino a quelli amministrativi. Introduce un tono di lealtà e compassione nelle relazioni che potrebbe mutare radicalmente la cultura della cura e la cultura delle organizzazioni sanitarie. E di un cambio di cultura c’è un estremo bisogno, in tanti settori della vita pubblica e moltissimo anche in quello sanitario, come mostra la narrazione dell’anziana paziente a proposito del suo good doctor.